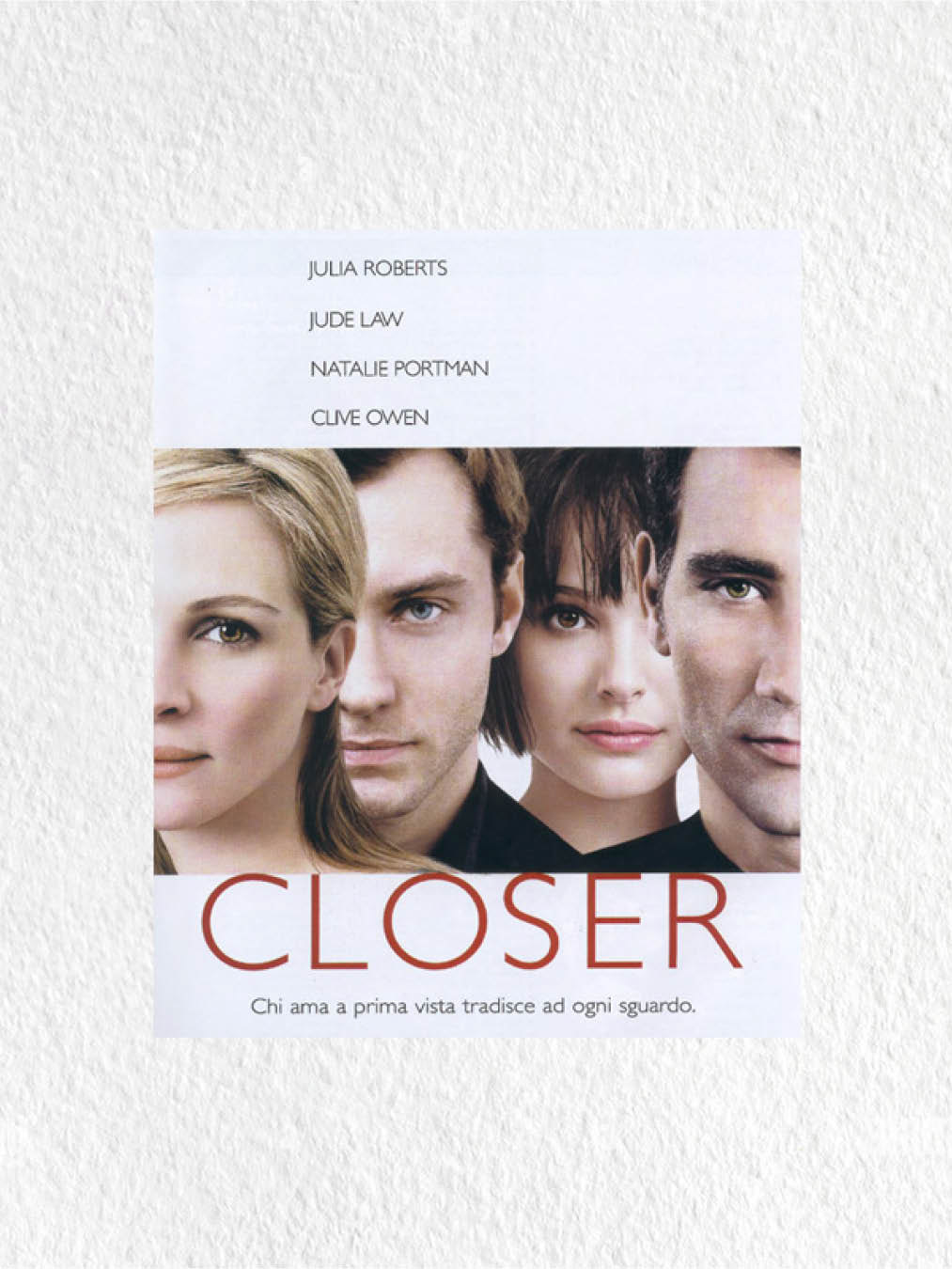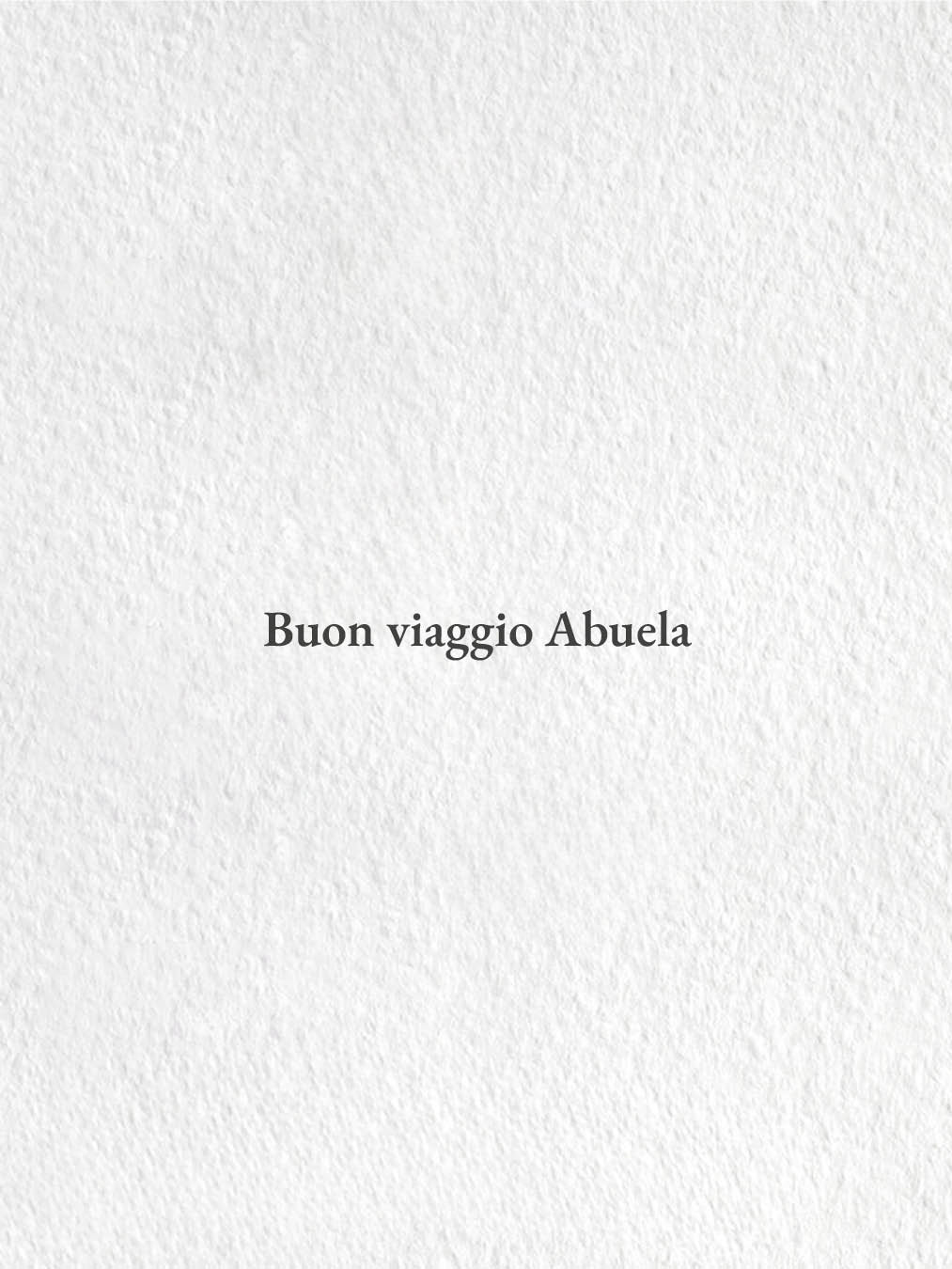Ricordo distintamente l’estate in cui mi sono innamorato della musica.
Era l’estate del 2001, avevo undici anni, e quella fu il nostro primo anno a Porto Cesareo, in Puglia, in un’epoca in cui il tempo sembrava muoversi più lentamente e le vacanze estive duravano tre mesi interi, pieni, senza interruzioni, senza impegni, solo mare, sole e sabbia bollente sotto i piedi.
Era l’estate in cui l’Italia si preparava definitivamente all’arrivo dell’euro, che avrebbe sostituito la lira nel giro di pochi mesi. A Genova, il G8 stava per trasformarsi in un incubo: il movimento no-global era in pieno fermento e le strade si sarebbero presto riempite di lacrimogeni, manganelli e rabbia. Le immagini della scuola Diaz e del corteo interrotto sarebbero diventate una ferita aperta.
Intanto, in televisione, si parlava degli squilli come forma di comunicazione, dei primi Nokia con suonerie personalizzate. A Porto Cesareo, si prendeva a malapena il segnale della Rai, ma bastava per sapere che qualcosa stava cambiando.
Ma soprattutto, era l’estate in cui il pop era ancora sovrano, anche se iniziava a perdere il suo splendore ingenuo: in radio passavano Lady (Hear Me Tonight) dei Modjo, Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue, It Wasn't Me di Shaggy e degli. Britney Spears era ormai una star consolidata, mentre i Backstreet Boys iniziavano a cedere il passo ai nuovi arrivati come *NSYNC, con Justin Timberlake che si preparava a brillare da solo.
Il jukebox sul lungomare alternava Survivor delle Destiny's Child a Whenever You Will Go dei The Calling, e io ricordo distintamente che su MTV si parlava del nuovo disco dei Radiohead, Amnesiac, anche se nessuno l’aveva ancora capito davvero — nemmeno io.
La Juventus si affidava ancora a Carlo Ancelotti, ma era già tempo di critiche e dubbi. Il Milan, invece, aveva appena richiamato Fatih Terim e costruiva il futuro che sarebbe esploso con l’arrivo di Ancelotti l’anno seguente. Shevchenko era ormai una certezza, mentre i discorsi di calciomercato, anche se non religione a casa nostra, arrivavano comunque come l’eco delle onde o delle chiacchiere tra adulti sotto l’ombrellone. E io ricordo ogni cosa.
Quell’anno mio padre ebbe un problema al lavoro e dovette tornare a Modena dopo poche settimane. Una sera ricevette una chiamata, e la mattina seguente partì in fretta sul suo Nissan Patrol, lasciando me e i miei fratelli con nostra madre e il caro cugino Giancarlo.
Ancora non lo sapevo, ma nonostante il cambio di programma, quella si sarebbe rivelata la vacanza più bella della mia vita, destinata a cambiare per sempre il mio rapporto con la musica.
Io e i miei fratelli ci svegliavamo ogni mattina con l’odore del caffè e del pane caldo che arrivava dalla cucina. Sul tavolo trovavamo già la colazione pronta: abbondante, ricca di sapori, dolce ma soprattutto salata, come vuole la tradizione peruviana. Era un piccolo rito quotidiano, semplice ma prezioso.
Ci sedevamo insieme, ancora un po’ assonnati ma tranquilli, con i capelli spettinati dal sonno e il costume da bagno già indossato, impazienti di andare in acqua. Mangiavamo lentamente, tra una chiacchiera svogliata e uno sbadiglio, la luce del mattino entrava dalle finestre annunciando un’altra giornata perfetta al mare.
Fuori, l’aria era già calda, ma dentro quella cucina si stava bene, tra le piastrelle chiare, l’odore del caffè appena fatto e le voci che si rincorrevano tra noi e Gian, che nel frattempo si svegliava un po’ più tardi, con i suoi modi lenti e precisi, da vero adulto libero e senza orari.
Ricordo che ogni mattina, faceva sempre la stessa cosa: dopo essersi riempito la tazza di caffè americano e aver smangiuchiato qualcosa, apriva le porte-finestre che davano sul portico, con una tazza di caffè americano in mano, e si fermava in piedi a guardare i riflessi del sole sul mare. Rimaneva lì, immobile, in silenzio, senza dire niente per lunghi minuti. Poi si girava verso di noi ed esclamava:
“Ma quanto cazzo è bella la vita?”
Gian, all’epoca, avrà avuto poco più di vent’anni, ma era già colto, intelligente e spigliato. Per noi era un adulto, un modello, un punto di riferimento. Soprattutto, era un grande appassionato e conoscitore di musica.
Io lo trovavo davvero spassoso: aveva un’ironia tagliente e non mancava mai una battuta, spesso con qualche parolaccia qua e là, seguita immancabilmente da un “oh, mi raccomando bastardelli, voi non ripetetele”.
Ci aveva anche insegnato a giocare ad un gioco a carte che si chiamava “Golpeado”, il quale – non so perchè – lo trovavavamo fottutamente divertente e non ci stancava mai.
Ci raccontava sempre tante storie sulla nostra famiglia, che ci aiutavano a capire da dove venivamo e a dare un senso a certi legami. E ascoltava con interesse le nostre, spesso totalmente sconclusionate.
Ripensandoci oggi, mi stupisce quanto fosse paziente con noi, considerando che era un ventenne all’apice del suo desiderio di fare festa.
Quando arrivava l’ora del pranzo Gian si metteva ai fornelli: era giovane ma era già un ottimo cuoco. Mia madre ancora oggi ricorda con un sorriso il patto che avevano stretto: “Tu cucini, io lavo i piatti”. E così andava a meraviglia, tutti contenti.
Dopo pranzo ci avviavamo verso la spiaggia – che era esattamente alla fine del vialetto sterrato, subito dopo aver attraversato la strada. Gian si portava sempre con sé una radio, una radio portatile della Sony con le casse gracchianti e alcuni CD.
I pezzi erano sempre gli stessi, si ripetevano in loop giorno dopo giorno — ma che pezzi! Col passare delle settimane quelle canzoni finirono per sedimentarsi dentro di me.
C’erano gli U2 con One e With or Without You; c’erano gli R.E.M. con Shiny Happy People, poi Losing My Religion, con quel mandolino inconfondibile, e Everybody Hurts, che sembrava parlare direttamente a certe malinconie che ancora non sapevo nominare e che sarebbero tornate anni dopo. Poi arrivavano gli Oasis, con Don’t Look Back in Anger, Stop Crying Your Heart Out e naturalmente Wonderwall, che ci sembrava la colonna sonora perfetta per ogni tramonto.
I Guns N’ Roses facevano capolino con Don’t Cry e Sweet Child O’ Mine, che che cercavo di suonare con una vecchia chitarra scordata, fallendo miseramente. E ancora Bitter Sweet Symphony e Lucky Man dei Verve, canzoni che sembravano fatte apposta per essere ascoltate in macchina, con i finestrini abbassati e il vento che ti sferzava il viso. C’era Heroes di David Bowie, che Gian ascoltava sempre in silenzio, quasi fosse un inno. E infine Head Over Heels dei Tears for Fears, con quel ritmo irresistibile che ci faceva sorridere senza motivo, mentre la giornata cominciava.
Erano canzoni che parlavano d’amore, di dolore, di nostalgia, di sogni, di ribellione. Io, pur non capendo ancora bene i testi, sentivo tutto: percepivo le emozioni nei ritornelli, nelle chitarre elettriche che si aprivano come orizzonti, nelle voci che facevano vibrare il petto — una sensazione che non ha mai smesso di accompagnarmi, nemmeno oggi.
Ricordo che guardavo Gian mentre ascoltava, gli occhi chiusi, mentre il sole calava lentamente all’orizzonte, tingendo il cielo di arancione e porpora. La sabbia, ormai tiepida dopo il calore del giorno, si raffreddava sotto l’asciugamano, e il mare davanti a noi rifletteva quei colori infuocati, sembrando cantare insieme a noi una dolce, malinconica melodia. Fu lì, in quel momento sospeso, che capii qualcosa di fondamentale: se avessi imparato ad associare un momento a una canzone, quel ricordo sarebbe rimasto per sempre.
In quel silenzio e in quella spiaggia compresi che la musica poteva essere tante cose, ma soprattutto memoria storica.
Quell’estate del ‘01 non mi insegnò a suonare uno strumento, non mi spiegò la teoria musicale, né mi trasformò in un DJ, ma mi insegnò la cosa più importante: che ascoltare musica è un gesto sacro, che certe canzoni, anche se non parlano direttamente di te, diventano parte della tua vita e della tua persona.
E io, quell’anno, capii di aver trovato il mio primo vero amore: la musica.
Oggi ci ripenso, riascolto quei brani, chiudo gli occhi e torno lì, su quel portico bianco con l’odore di salsedine nell’aria, il suono del mare in sottofondo, le risate dei miei fratelli — e mi rendo conto che Gian aveva ragione:
quanto cazzo era bella la vita allora?